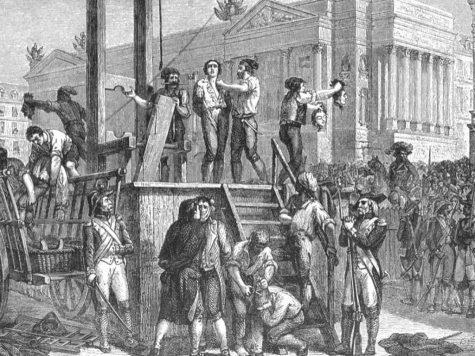Negli anni Sessanta e Settanta i cinefili più militanti e agguerriti combatterono una battaglia per dimostrare che il vero cinema politico era più facilmente quello di genere che non quello d’autore. Dicevano quei critici: mica sono rivoluzionari i film di Elio Petri o di Luchino Visconti, o Ingmar Bergman e Costa Gravas, la rivoluzione sono i western di Sergio Leone e Sollima padre, o quelli di Sam Peckinpah negli Usa, i thriller di Mario Bava, gli horror di Romero, il soft-core di Russ Meyer. L’invito al pubblico italiano era a non farsi traviare dalla trame, dai giudici eroi delle pellicole anti-mafia o dai partigiani delle epopee anti-fasciste. Il vero cinema d’impegno, sostenevano, non è quello che esplicitamente affronta questioni civili o politiche – quella è roba buona per i palati poco fini del pubblico “democratico” – bensì quello che usa i codici dello spettacolo per rielaborarli a fini politici. La rivista Ombre rosse, che di questa tendenza era l’espressione più politicizzata, si vantava di preferire “la sottocultura autentica alla cultura media-borghese, Maciste a Pasolini, Riccardo Freda a Jacques Tati, Frédéric Dard a Carlo Cassola”. Il primo numero di Ombre rosse, anno 1966, uscì con in copertina il Burt Lancaster de I professionisti, western di Richard Brooks. Un manifesto teorico: una pellicola fuori dai canoni tradizionali del cinema “alto”, un protagonista “fuorilegge” e un mezzo, il fucile (i ragazzi di Or non amavano invece Leone, ma questo è un vizio di cui eventualmente renderanno conto nel giorno del giudizio).
Era una visione manichea ma non priva di forza e argomenti. Depurata delle sue velleità sovversive, frutto del clima dell’epoca, questa scuola di pensiero importò in Italia la critica revisionista che i Cahiers du cinéma avevano sviluppato quindici anni prima in Francia: combattere il cinema cosiddetto di papà, patinato e ordinato, e rivalutare la forza dello spettacolo, la finezza della forma, dunque i noir americani anni Quaranta, Hithcock, Hawks e Ford, persino certa selvaggia fantascienza Usa anni Cinquanta che pareva destinata a essere sepolta insieme ai drive-in del Colorado.
Mi chiedevo l’altra sera, appena fuori dal cinema Adriano di Roma, cosa avrebbe pensato uno di quei critici dopo aver visto Suburra. In teoria, Suburra è l’inveramento di certe aspirazioni sull’uso politico del cinema di genere. Un film sulla corruzione ma senza buoni e cattivi, senza messaggio pacificatore, senza “linea”. Al contrario, cinema di genere spintissimo, la mala come nei polar francesi, la pioggia metafisica alla Blade Runner, le sparatorie che neanche in Michael Mann, lo splatter dei pestaggi, droga, sbranamenti, orge, pisciate dal balcone. Nella Roma di Sollima si vive e si muore molto peggio che nella Los Angeles di William Friedkin. Solo che da questo lungo viaggio pulp si esce con la sensazione di non aver visto nulla di Roma vera. La suburra di Sollima, bravissimo regista, è come le Termopili di 300, un rutilante graphic novel che trasfigura e spettacolarizza con grande maestria fino a perdere ogni contatto con la realtà. È cinema, e può andar bene così, a patto di dismettere ogni ambizione di lettura sociale e politica, che pure è rinuncia singolare per un’opera che nasce su un romanzo, firmato da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini (anche sceneggiatori del film), che legittimamente rivendica il merito di aver anticipato trame e personaggi di Mafia capitale. L’operazione Suburra è vinta se l’obiettivo è il grande ritorno al blockbuster italiano, la definitiva rottamazione dei vizi del cinema italiano medio anni Novanta, e cioè l’autorialismo senza artigianalità, il morettismo senza Moretti, il fellinismo senza Fellini e l’antonionismo senza Antonioni (che peraltro traballava pure con Antonioni medesimo). È invece persa se l’obiettivo è raccontare l’Urbe del 2015, e il Paese di cui è capitale. È persa, se si parte per fare l’American Tabloid italiano e si finisce con il sosia del papa come in un instant movie di Giuseppe Ferrara o con un’improbabile Favino che rincorre la macchina di Silvio Berlusconi pronunciando battute contro la magistratura un po’ troppo didascaliche per un film che ha più da mostrare che da dire.
Chissà insomma cosa direbbe quel critico, delle sue vecchie teorie di un tempo. Forse farebbe autocritica, dietrofront, auto-da-fé. Magari lo farebbe sicuramente, se nel frattempo gli è anche capitato di vedere Non essere cattivo. Pure nella Roma di Caligari si taglia la droga come in Scorsese e si muore ammazzati sotto le foto delle spiagge caraibiche, come succede ai protagonisti dei melò criminali di Brian De Palma, eppure il film è fuori da ogni genere, autoriale nel senso più classico, personale come un’impronta digitale e la sua forma inattuale è quanto di più potente il cinema italiano abbia saputo produrre negli ultimi anni per raccontare il lavoro, il non lavoro, le periferie, la vita vera di Roma e della sua tragicommedia umana.
Teniamoceli tutti e due, questi film. Ma mettiamoli bene in ordine di classifica.
Ps. Scopro ora che quel critico non c’è nemmeno bisogno di immaginarlo. Su Suburra Goffredo Fofi, anima di Ombre rosse, ha scritto questo. Ma non è un’autocritica…